MALA TEMPORA CURRUNT di Alessandro Iovinelli (narrativa)
NARRATIVA
MALA TEMPORA CURRUNT DI
Alessandro Iovinelli
NARRATIVA
1. Faber est suae quisque fortunae?
Non sono mai stato un giocatore, pur avendo imparato abbastanza bene i principali giochi di carte (le napoletane e le francesi) e avvertendo per quelli di azzardo un’irresistibile attrazione contro cui deve aver funzionato l’influenza di mia madre, per la quale la vita era una questione di lavoro, sacrificio, dedizione incondizionata alla missione che si è scelta. Quanto ai successi, se e quando arrivano, ciò dipende soltanto da noi o, meglio, dal modo in cui abbiamo affrontato e risolto i problemi incontrati lungo il cammino.
Tuttavia, lo spirito del giocatore che con la posta puntata spera di vincere la scommessa, la riffa, la lotteria, mi deve essere rimasto appiccicato nel codice genetico trasmessomi da mio padre (e le precedenti generazioni della famiglia paterna) e l’ho trasferito dai cavalli e dalle carte in un altro campo, fra l’altro ben più aleatorio, imprevedibile e arbitrario: la letteratura.
Non mi riferisco tanto alla scrittura, giacché quella l’ho concepita sempre per me stesso, senza preoccuparmi mai del destinatario, se non nel caso in cui i miei versi erano dedicati alla donna amata, la quale allora diveniva per me la lettrice ideale, colei, probabilmente l’unica, che avrebbe potuto comprenderli e da cui mi aspettavo che le piacessero e che vi si riconoscesse. Mi riferisco invece a quel sistema che passa tra l’autore, il testo e il pubblico e che da duemila anni e più chiamiamo letteratura. In questo caso l’esperienza di una vita mi obbliga a sottoscrivere la drastica sentenza di Schopenhauer: in nessun campo la disonestà è così grande come nella letteratura.
Il giorno in cui ho cominciato a pubblicare i miei scritti, soprattutto quelli narrativi, ho cambiato inevitabilmente le attese e le finalità. Non che mi aspettassi da un momento all’altro di scalare le classifiche dei best-seller – non sono mai stato ingenuo fino a questo punto – ma ogni volta mi illudevo che l’intenzione con cui avevo concepito la mia opera fosse chiara e raggiungesse il suo scopo.
A metà degli anni Ottanta pubblicai Demenza precoce, che aspirava a essere l’autoritratto di una generazione – i giovani degli anni Settanta – ma i pochi che l’hanno letto non l’hanno capito e tanto meno vi si sono riconosciuti. Al contrario, Calluna vulgaris (uscito nel 2008 per Mobydick) ha avuto una migliore accoglienza. È stato perfino tradotto in croato nel 2015 (il libro era edito da Mala Zvona e la traduzione era di Tanja Čale). In genere i suoi lettori l’hanno trovato gradevole e divertente, ma nessuno degli addetti ai lavori del mondo del cinema, al cui esame l’avevo sottoposto, ha mai pensato di ricavarne un film, nonostante io l’avessi elaborato proprio come l’ipotesto di una commedia cinematografica (i miei autori di riferimento erano stati Ernst Lubitsch, Howard Hawks, Billy Wilder e, naturalmente, Woody Allen).
 L’ennesimo
smacco (ma non l’ultimo, perché al catalogo mancava ancora Magic mountain uscito
nel 2020 per Robin editore) è toccato a L’uomo
che amava Kirsten Dunst (2012), là dove l’amore per il cinema non era
affatto generico, ma si personificava piuttosto in un’attrice in carne e ossa. Che
ha occupato un posto centrale nel mio
Olimpo di amorose visioni suggerite dal cinema, fin da quando la scoprii nel
ruolo epifanico di Lux, una delle
sorelle Lisbon, il cui tragico destino è rappresentato in The Virgin Suicides
(1999).
L’ennesimo
smacco (ma non l’ultimo, perché al catalogo mancava ancora Magic mountain uscito
nel 2020 per Robin editore) è toccato a L’uomo
che amava Kirsten Dunst (2012), là dove l’amore per il cinema non era
affatto generico, ma si personificava piuttosto in un’attrice in carne e ossa. Che
ha occupato un posto centrale nel mio
Olimpo di amorose visioni suggerite dal cinema, fin da quando la scoprii nel
ruolo epifanico di Lux, una delle
sorelle Lisbon, il cui tragico destino è rappresentato in The Virgin Suicides
(1999).
2. Arrectis auribus
Quando questo libro andò in stampa, la pubblicità apparve sul sito dell’editore e io entrai in possesso di qualche copia campione. Subito pensai di inviarne una a Kirsten. Chissà perché, ma mi immaginavo che lei trovasse qualcuno che capisse il testo in italiano e apprezzasse la sua metamorfosi in personaggio letterario, magari spingendola a farsi madrina e ispiratrice di una versione in inglese. E a quel punto chi avrebbe potuto escludere un risultato stupefacente? La storia della letteratura italiana è piena di scrittori scoperti prima all’estero e poi in patria, a cominciare da Svevo, il quale senza Benjamin Crémieux e Valéry Larbaud non sarebbe mai assurto alla fama di gigante del Novecento, ma sarebbe probabilmente rimasto un bizzarro imprenditore di vernici sottomarine, la cui passione per la letteratura era tramandata dalle cronache familiari triestine.
Mi rendo conto adesso che, coltivando una tale aspirazione, in quel periodo il mio cervello fosse abbastanza obnubilato. Avrei letto in seguito che è tipico della depressione alternare momenti di sconforto e pessimismo assoluti ad altri di segno opposto, durante i quali la mente vagheggia rivalse e palingenesi mirabolanti. Evidentemente, L’uomo che amava Kirsten Dunst è nato con impressi i segni di questa sindrome.
 Ciò
riconosciuto, va aggiunto però che mi mossi con prudenza e circospezione,
seguendo il protocollo previsto in questi casi. Così non mi rivolsi
direttamente a lei, bensì al suo agente, il cui indirizzo avevo reperito grazie
a International Movie Data Base, una sorta di bibbia per cinéphiles e cinematografari, redassi in inglese una lettera
d’accompagnamento al libro, cui feci seguire qualche tempo dopo una mail per
sapere se la spedizione avesse avuto buon esito.
Ciò
riconosciuto, va aggiunto però che mi mossi con prudenza e circospezione,
seguendo il protocollo previsto in questi casi. Così non mi rivolsi
direttamente a lei, bensì al suo agente, il cui indirizzo avevo reperito grazie
a International Movie Data Base, una sorta di bibbia per cinéphiles e cinematografari, redassi in inglese una lettera
d’accompagnamento al libro, cui feci seguire qualche tempo dopo una mail per
sapere se la spedizione avesse avuto buon esito.
Non avendo ricevuto alcuna risposta in entrambi i casi, mi spazientii e decisi di cambiare strategia. Essendo abbastanza informato sulla vita di Kirsten, dalla nascita (avvenuta a Point Pleasant il 30 aprile del 1982) alla succesiva carriera cinematografica (peraltro intrapresa giovanissima e che le valse all’età di 12 anni una nomination ai Golden Globe come migliore attrice per la sua interpretazione in Intervista col vampiro), sapevo che a quei tempi abitava con la madre in una zona di Los Angeles, un po’ fuori città, esattamente a Toluca Lake, un piccolo e ameno centro dove possedevano una graziosa villetta.
Anche negli Usa esistono le “pagine bianche”, sicché supposi che, se un nome vi fosse comparso, sarebbe stato quello di mamma Inez. La mia ricerca centrò l’obiettivo. Composi una nuova lettera con un tono cortese benché formale, la inclusi nel pacco con il volumetto e spedii il tutto.
Kirsten non mi rispose. È pur vero che a questo punto non mi aspettavo più colpi di scena clamorosi, alla stregua del mio protagonista (queste svolte succedono soltanto nell’universo della fiction). Purtuttavia, contavo di ricevere almeno un biglietto, una cartolina, una foto con l’autografo. E invece niente.
Non me la sono presa più di tanto: come avrebbe potuto accadere altrimenti? È americana, le arriva un pacco da parte di uno sconosciuto, il libro è redatto in una lingua che lei non parla, capisce che la riguarda dalla foto della copertina e dal titolo, ma l’una e l’altra circostanza potrebbero indispettirla o quanto meno lasciarla indifferente, se non addirittura apparirle più sgradite di quanto supponessi. Chissà quanta posta le arriva, magari neanche la guarda, nel mare la singola goccia passa inosservata. Perché mai avrebbe dovuto rispondermi?
Questa fu la spiegazione che mi diedi sul momento, poi un giorno capii che le cose erano andate diversamente e che – se non il diavolo – di certo la sfortuna, ovvero la grande nemica di tutti i giocatori, effettivi o mascherati, ci aveva messo lo zampino.
3. Dura lex, sed lex
Quando le avevo spedito il libro all’indirizzo di casa, ero convinto di aver escogitato una gran furbata, in realtà avevo commesso un errore fatale. Non mi ricordo dove, ma lessi una notizia che poi trovai confermata su molti altri siti della rete. In quegli stessi giorni la bionda ed eterea protagonista aveva ottenuto da un giudice californiano la condanna di un molestatore a non avvicinarsi a meno di cento yard (per l’esattezza, 91,44 metri) dalla sua abitazione. I giornali riportavano la storia con molti particolari. Si trattava di un cittadino francese, che aveva venduto la propria dimora di Digione, abbandonando tutto e partendo alla volta degli USA con lo scopo di conoscerla. Le aveva scritto una cinquantina di lettere – tutte rimaste senza risposta – e le aveva perfino dedicato un romanzo, che aveva in ogni modo cercato di consegnarle di persona.
Perciò l’aveva spesso attesa davanti casa, ma invano o, peggio ancora, poiché aveva finito per essere scambiato per un volgare paparazzo o un pericoloso maniaco.
«Sono spaventata per la mia sicurezza, per quella della mia famiglia e per i miei amici che vengono a trovarmi a casa» si legge nelle carte giudiziarie.
Di qui la sentenza del giudice, peraltro confermata in un appello successivo, il quale estese le yard a 500 (cioè, 457,2 metri) e prolungò la durata del divieto fino al 2015.
Ho letto in seguito un’intervista rilasciata dal romantico stalker transalpino. La sua versione è un po’ diversa, ma non contraddice i fatti a lui contestati.
«Volevo soltanto che lei mi rispondesse» ha dichiarato Jean-Pierre Prudhon. «Se lei mi avesse detto anche una sola volta: “Non desidero parlarle”, allora avrei lasciato perdere tutto. Invece mi ha denunciato alla giustizia. Mi ha proprio deluso. Non ho più voglia di vederla. Ho creduto in un sogno. Oggi mi rendo conto che la mia è stata una cazzata».
Leggendo le motivazioni addotte in sua difesa, considerai il povero Jean-Pierre, se non come un sodale, di certo una sorta di mio parente, magari un po’ troppo incauto e sprovveduto, con il quale avrei potuto solidarizzare, nonostante la improvvida coincidenza tra la sua corte ostinata e l’arrivo del mio pacco fosse stata verosimilmente la causa dell’insuccesso del mio piano. Fra l’altro, anch’io avevo spedito la busta dalla Francia e già immaginavo la scena davanti alla cassetta postale di Mrs. Dunst: ancora posta? Ancora un altro mittente francese? Forse era un nome fittizio del medesimo molestatore, stavolta camuffato con uno pseudonimo. E via nella pattumiera io e il mio Doppelgänger irruente, improvvido e pazzerello.
Lo sapevo (e l’ho scritto pure nel mio libro): non è più tempo di amori cortesi e anzi, quanto più un sentimento è assoluto, tanto più rischia di essere scambiato per follia – o come si dice oggi: stalking. Viviamo in un’epoca in cui Humbert Humbert sarebbe arrestato per pedofilia, Werther ricoverato in una clinica psichiatrica, quanto poi agli immortali Consalvo, Cyrano de Bergerac e Florentino Aziza, ai miei occhi i più autentici eroi dell’amore assoluto ma disperato, sarebbero sicuramente condannati da qualsiasi tribunale come minacciosi molestatori.
Il problema non si pone soltanto per i maschi, perché i nostri tempi sono ricchi altresì di personaggi femminili caratterizzati da un trattamento psichiatrico del loro sentimento amoroso. Il primo caso che mi viene in mente è Alex Forrest di Attrazione fatale (fim del 1987), l’amante di un’avventura di un celebre avvocato, che si trasforma in una pericolosa minaccia contro l’incauto adultero e in seguito anche contro sua moglie e perfino la loro figlioletta. L’ultimo esempio proviene invece dalle serie tv ed è Baby reindeer (2024), là dove Richard Gadd si è ispirato a una sua esperienza autobiografica. Qui ci troviamo in presenza di una stalker; che lo perseguita tempestandolo di email e messaggini, soltanto perché lui, inteneritosi per la sua palese indigenza, le ha offerto una tazza di tè nel pub dove lavorava come barman.
Allora è forse tra gli etero, non importa se maschi o femmine, che si palesa il disturbo psicotico noto col termine di erotomania, vale a dire l’attaccamento morboso a una figura idealizzata, da cui per giunta ci si crede ricambiati?
Non è questa l’illazione cui giunge L’amore fatale (1997), il romanzo di Ian McEwan che narra di Joe Rose, uno scrittore, del quale si innamora Joe Perry, fra l’altro un fanatico religioso definibile perlomeno come neuro divergente. I due si erano incontrati per caso in una circostanza tanto improbabile quanto rocambolesca: entrambi avevano cercato invano di salvare la vita a uno sconosciuto rimasto attaccato a una mongolfiera che stava decollando sospinta dalla forza del vento. Tuttavia, Joe Perry non è un caso isolato, bensì uno dei tanti gay che soffrono di tale disturbo.
La seconda appendice spiega che la storia narrata nel libro si ispira a un fatto realmente accaduto, aggiungendo non trattarsi di un caso eccezionale, ma che anzi annovera numerosi precedenti tutti menzionati nella letteratura scientifica della cosiddetta sindrome di Clérambault, Si tratta di un quadro sintomatico fondato sulla convinzione da parte del malato di di essere amato da qualcuno – il quale invece non conosce neppure l’individuo affetto da questa dissociazione psicotica. Nella casistica citata dalla letteratura scientifica rinveniamo uomini eterosessuali, donne eterosessuali e omosessuali.
Pertanto, se la sindrome di Clérambault funziona come la morte nella poesia di Totò, ‘A livella, essendo una legge universale che riguarda tutti gli umani senza alcuna distinzione, si potrebbe dedurre che l’amore non è altri se non una variante “benigna” della stessa patologia. Anzi, da un punto di vista assiomatico, tra le due forme vince l’amour fou alla Adele H del film di Truffaut, l’unico che non passa mai e resiste tutta la vita, ma soltanto perché è una manifestazione “maligna”, inguaribile e mortale del medesimo morbo. Diversamente l'amore dei comuni mortali finisce, passa e non dura o, come direbbe Frédéric Beigbeder: dura tre anni. L’unico a esserci per sempre è l’amore degli psicopatici. Quello è il vero endurance love – come recita il titolo originale del romanzo di McEwan – ovvero amore duraturo, persistente, eterno.
Nella normalità invece sono intrinseche le categorie dell’impermanenza, della finitezza temporale o – se è consentito adoperare le leggi della fisica termodinamica – dell’entropia.
Giunto a tali conclusioni, ci misi una pietra sopra e non ci pensai più. Poi qualche anno più tardi lessi un’altra notizia che mi inquietò, se possibile, maggiormente.
4. Quomodo
Nell’estate del 2014 Le Magazine Littéraire rendeva noto che il tribunale di Parigi aveva dato ragione, sia pure parzialmente, a Scarlett Johansson nel processo da lei intentato contro lo scrittore Grégoire Delacourt per aver sfruttato fraudolentemente i diritti della sua personalità.
(Scarlett Johansson)
Tutto era nato dal romanzo La première chose qu’on regarde (cioè La prima cosa che si guarda), nel quale la protagonista è una modella dalla strabiliante somiglianza con l’attrice americana, tanto che nel suo ambiente tutti la chiamano Scarlett e lei stessa (pirandellianamente) finisce per identificarvisi, prendendo in prestito tratti della personalità e finanche situazioni ed episodi della biografia. A differenza del mio libriccino, quello di Delacourt ha avuto un discreto successo e ha venduto più o meno centomila copie, giungendo infine tra le mani di Scarlett, che non l’ha per nulla gradito, facendo causa allo scrittore e al suo editore Lattès.
Delacourt si è dichiarato stupito di una reazione così offesa e risentita nei confronti di un’opera che intendeva essere prima di tutto un omaggio verso la stella di Hollywood. In un’intervista si è così espresso al riguardo: «Ingenuamente pensavo che il libro le sarebbe piaciuto. Non pensavo che mi avrebbe mandato un mazzo di fiori, ma almeno offerto un caffè».
Gli avvocati hanno citato in favore del loro assistito la libertà di espressione propria di ogni creazione letteraria e, più in generale, lo statuto autonomo dell’universo letterario rispetto ai parametri della realtà e quindi della cronaca, della storia o della privacy. Ma non c’è stato niente da fare: il tribunale ha dato ragione alla querelante e quindi condannato l’editore a pagare una multa di 2.500 euro più le spese giudiziarie. Certo, sempre molto meno di quanto richiesto dai legali dell’attrice: 50.000 euro nonché il macero per le copie ancora invendute.
5. Tolle, lege
Il mio amico Silverio conosceva come sempre non solo la storia da me narrata, ma anche la genesi del racconto e il processo di costruzione del personaggio letterario a cui avevo dato vita sulla pagina. Vi sono infatti tre livelli di significato nella mia Kirsten Dunst. Il primo (e il più superficiale) sta nella sua carriera cinematografica e coincide con l’attraversamento critico dei maggiori ruoli da lei interpretati. Il secondo livello riprende la trovata della Rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, giacché la creatura vagheggiata sullo schermo si materializza nella vita immaginaria di Adriano, cioè il protagonista del mio romanzo, interagendovi come se fosse la fanciulla dei suoi sogni. Infine, il testo pretende di aver scoperto la vera natura di Kirsten, più vera della vera, ora finalmente svelata nella sua autenticità.
Ma chi era l’autore del percorso rappresentato, là dove la finzione – per dirla con il Pessoa di Tabucchi – è trascendente e l’atto di fingere produce la verità suprema? Il sottoscritto. Dunque, io sarei stato giudicato come il responsabile del testo. Davanti alla legge sarei stato l’imputato. Di sicuro, il colpevole. Anche perché la mia non era manco una copia, bensì proprio Kirsten, la persona reale, anzi Kiki, come a un certo punto la evoca Adriano, servendosi del soprannome con cui la chiamano in famiglia.
«Ti rendi conto?» ho detto al mio amico. «E la protagonista del romanzo di Delacourt non era nemmeno Scarlett, bensì una sosia. Allora quale sarebbe stata la condanna nel mio caso, visto che mi sono appropriato della figura di Kirsten come se ne fossi io il creatore? Se la Johansson ha chiesto 50.000 euro di risarcimento nonché la distruzione delle copie, mi domando che cosa Kirsten avrebbe potuto pretendere».
Silverio lasciò il mio interrogativo sospeso in aria qualche secondo e poi rispose con la franchezza che possono (e debbono) usare soltanto gli amici che ci conoscono da una vita:
«L’ergastolo».
[Questo testo è la rielaborazione di un estratto ripreso da un racconto che fa parte di una raccolta, La scala d’oro, pubblicata da Robin edizioni nel 2015.]
ALESSANDRO IOVINELLI
BIONOTA
Fondatore e direttore scientifico di TeclaXXI, Alessandro Iovinelli (Roma, 1957) ha conseguito la laurea in lettere (Roma, La Sapienza) e il dottorato di ricerca in “Culture et Société en Italie du Moyen-Age au XXème siècle”, (Parigi, La Nouvelle Sorbonne).
È poeta, narratore, critico e regista teatrale. Ha pubblicato libri di poesia, racconti, saggistica, nonché tre romanzi.



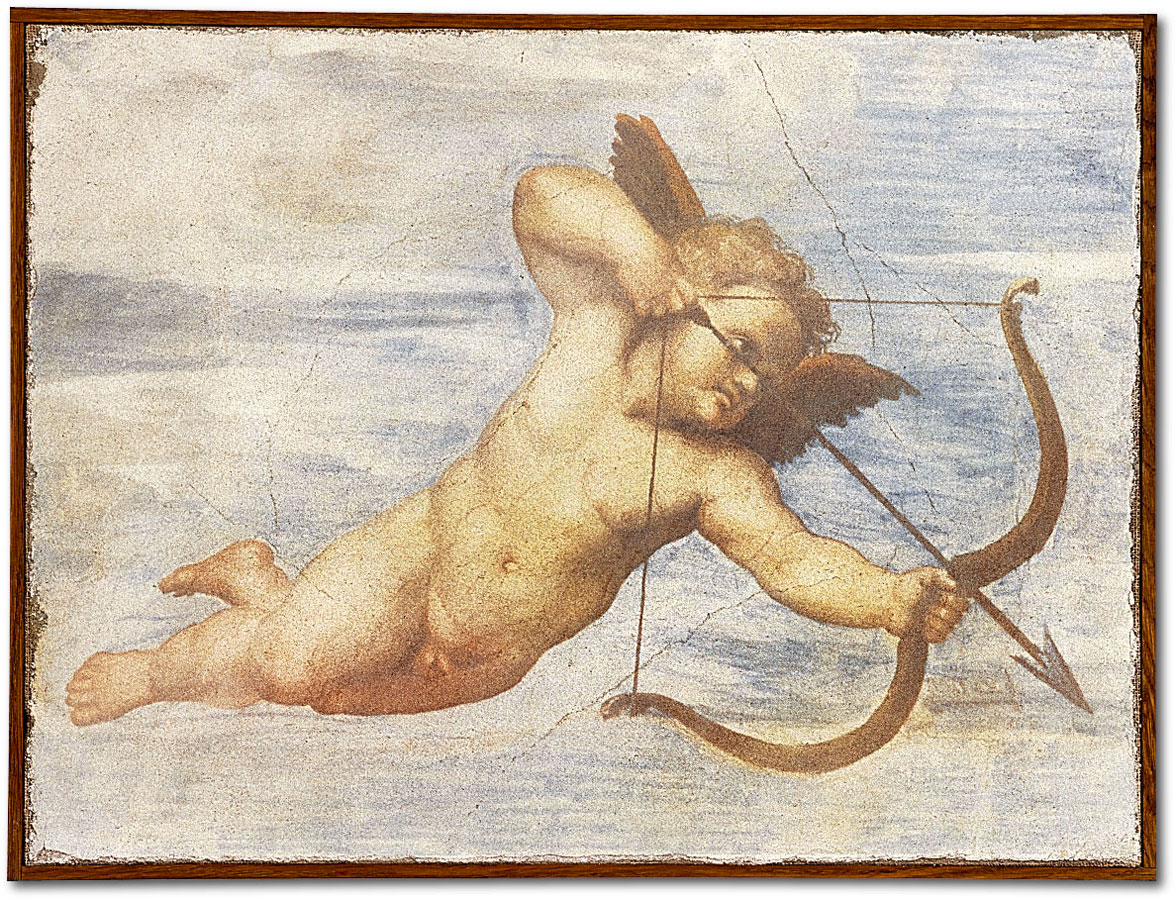


Questa lettura me la son tenuta fino ad ora prima di dormire.Fluida come sempre la scrittura e con tanta ironia e un po di stupore .Comunque son d'accordo l'amour fou è quello per cui vale la pena vivere e Humbolt Humbolt e Florentino Aziza mi hanno sempre accompagnato. GRAZIE ALESSANDRO. F.L.
RispondiEliminaMi sono molto divertita a leggere questo articolo , “te la sei rischiata grossa” con Kirsten Dunst ! L’amore fou oggi hai detto bene sarebbe considerato stalking, anche se paradossalmente con l’avvento dei social tutto è diventato più aggressivo e soprattutto esplicito! Ma ahimè al contrario libri classici se fossero usciti oggi quante querele avrebbero avuto? Monica Rufini
RispondiEliminaÈ sempre gradevole ed istruttivo leggerti! 👏👏👏 Giovanna Romanelli
RispondiEliminaAh! l’amore, l’amore, quante cose fa fare l’amore… Complimenti Alessandro, è proprio un bel racconto. Mi fa venire in mente da un lato il tema dell’amore virtuale (molto più esteso nel tempo e nello spazio di quanto non si possa supporre di primo acchito) e dall’altro il tema della melancholia amorosa - che nel medioevo veniva trattato con ferri roventi poggiati sulla testa di chi ne era affetto, per cancellare l’immagine ossessiva della persona amata.
RispondiEliminaEduardo Rebulla
Ah! l’amore, l’amore, quante cose fa fare l’amore… Complimenti Alessandro, è proprio un bel racconto. Mi fa venire in mente da un lato il tema dell’amore virtuale (molto più esteso nel tempo e nello spazio di quanto non si possa supporre di primo acchito) e dall’altro il tema della melancholia amorosa - che nel medioevo veniva trattato con ferri roventi poggiati sulla testa di chi ne era affetto, per cancellare l’immagine ossessiva della persona amata.
RispondiEliminaEduardo Rebulla