La peste a Torino nel XVII secolo (storia) ~ di Riccardino Massa - TECLAXXI
STORIA
Riccardino
Massa
La
peste a Torino nel XVII secolo
Per
una buona parte degli abitanti di Torino, via Gianfrancesco Fiochetto (Spesso
erroneamente chiamata via Fiocchetto) non è altro che una strada di poche
decine di metri collocata nelle vicinanze della celebre zona mercatale di Porta
Palazzo. È conosciuta per lo più dal fatto che insiste una grande stazione di autobus.
Un capolinea di torpedoni che da quel luogo partono per raggiungere la
provincia e spesso anche la Valle d’Aosta. I torinesi dimenticano, invece, che
l’ufficio toponomastico della città ha intitolato detta via a un benefattore:
il responsabile della salvezza di migliaia di cittadini durante la peste che
colpì gran parte dell’Italia settentrionale agli inizi del Seicento. Per
capirci meglio, si tratta della stessa pandemia di cui parla il Manzoni,
riferendosi a Milano, nel celebre saggio (poi appendice del capitolo XXXII dei
Promessi Sposi) “Storia della colonna infame”. Chi era Fiochetto ce lo dice la
Storia₁; medico e pedagogo, ma soprattutto archiatra presso la corte
dei Savoia. Qualche decennio fa avremmo definito questa figura con il termine
“Medico Condotto” (prima del più moderno termine di medico di famiglia e poi di
medico di base), invece agli inizi del XVII secolo lo avremmo chiamato
Protomedico, intendendo con questo termine il responsabile della sanità
pubblica, in particolare del Ducato di Savoia. Già accompagnatore medico del
Principe Filiberto di Savoia nelle sue scorrerie europee₁ durante la
Guerra dei trent’anni (celebre fu la terapia che intraprese sul duca per
curarlo dalle febbri prese dopo un bagno nel Manzanarre in Spagna), raggiunse
in massimo prestigio nelle decisioni prese, atte a contenere il contagio della
peste che imperversò a Torino negli anni 1630-1631₂.
Capiamoci!
All’epoca poco si conosceva del batterio in seguito denominato Yersinia pestis₃
(battere isolato da Alexandre Yersin solo nel 1894 durante l’epidemia di Hong
Kong), di come si presentava, nelle sue tre forme di patologie, ma soprattutto
quali erano le motivazioni dello scaturire della malattia (Oggi riconosciuta
derivante dalla pulce del ratto, capace di infettare anche l’uomo). Infatti,
all’inizio del XVII secolo ancora oscure erano le teorie sulle quali si basava
la medicina. Tutte quante, comunque, influenzate da una infondata cultura
pseudo scientifica. Molto ci si riferiva ai testi antichi. Indicative erano le parole di Ovidio nelle “Metamorfosi”
₄, oppure la considerazione degli eventi straordinari come il passaggio
di comete₅, e come non ricordare che la peste poteva essere
considerata una punizione divina₆. Non che il testo originale
scritto dal Fiochetto₇ fosse in grado di determinare l’origine della
malattia, ma certamente ha contribuito a capire di più come fare per cercare di
contenere il contagio, che fu terribile per l’epoca. Dobbiamo comunque
ricordare che il primo dato statistico, relativo al 1560 (prima del
trasferimento della capitale del Ducato da Chambery a Torino), ci parla di una
popolazione abitante in città formata da circa 20.000 persone (110 milioni in
tutta Europa). Milano all’epoca già ne contava circa 110.000. Solo con la fine
della pestilenza Torino tornò a crescere. Con il censimento commissionato da
Carlo Emanuele I nel 1631, dopo la peste, gli abitanti di Torino aumentarono al
numero di 36.649.
Nel
periodo della peste molti se ne andarono via dalla città, emigrarono anche solo
per un breve periodo. La paura era tanta, anche perché ogni giorno si vedevano
file di cadaveri che venivano inviati nelle fosse comuni. Di sola peste
morirono più di 8.000 abitanti (dati in difetto non essendo all’epoca nessun
tipo di trascrizione anagrafica). Alla fine dell’epidemia dobbiamo pensare che
la popolazione torinese residente in città era rimasta formata da sole 3.000
persone. Le genti fuggirono nelle zone salubri della montagna, dove pareva che
la peste non arrivasse. Anche i nobili se ne andarono. Se il Duca di Savoia
riparò a Fossano (70 chilometri di distanza), l’Arcivescovo di Torino, sua
Eminenza Carlo Broglia, si trasferì a Chieri (cittadina all’epoca a 40
chilometro dalla città).
Benché
la crisi sanitaria si facesse pesante, rimasero in città a contrastare
l’epidemia due importanti personaggi. Uno fu l’allora il primo sindaco
Gianfrancesco Bellezia (per meriti acquisiti, successivamente, nel 1635,
Vittorio Emanuele I lo nominò consigliere senatore ed avvocato patrimoniale
generale della Camera dei Conti, e in seguito acquisì anche il titolo nobiliare
di Conte), l’altro fu appunto il protomedico Gianfrancesco Fiochetto.
Pur
essendo un medico, e quindi certamente meno superstizioso di tanti suoi
concittadini dei ceti più popolari, il Fiochetto era comunque figlio del suo
tempo. All’epoca la medicina era ancora intrisa di pratiche terapeutiche
condizionate dal rapporto con il sacro. Spesso le cure rientravano nella scia
delle tante manifestazioni della religiosità popolare. Un sincretismo che
amalgamava rituali religiosi con formule simboliche influenzate da tradizioni
popolari legate a condizionamenti naturali, spesse volte ritenute pratiche di
stregoneria da parte delle autorità ecclesiastiche₈. Nel
passato la medicina colta non era una scienza o una tecnica sviluppata da
conoscenze sperimentali, si basava principalmente su convinzioni empiriche più
legate alla filosofia che alla fisiologia umana. Ciò nonostante, fu il
Fiochetto ad ispirare la politica sanitaria all’autorità politica cittadina.
Come è successo con la moderna pandemia da Covid 19, è la scienza che deve
ispirare la politica ad assumere i giusti atteggiamenti e le decisioni anche in
ordine ai divieti imposti. E questo permise di evitare l’aumento di contagi che
avrebbero potuto cambiare totalmente la Storia di una città (vista anche la
limitata popolazione residente) e probabilmente, volendo prefigurare una
immagine futuribile, la stessa Storia d’Italia nei secoli successivi.
Fu
il Fiocchetto ad indicare di evitare gli assembramenti e a imporre (anche
complice la paura) di non procedere a processioni religiose che avrebbero
moltiplicato il contagio tra i fedeli assembrati. Svariate furono le scelte
motivate da detto protomedico e che sono inserite nella quarta parte del
Trattato₉ da lui indicate e successivamente pubblicate a fine
pandemia, probabilmente per futura memoria dei posteri. Certo l’esperienza
precedente influenzò molto le decisioni. Infatti, nel corso della sua
esposizione Gianfrancesco Fiochetto fa riferimenti ad un protomedico siciliano
(Giovanni Filippo Ingrassia) che nella seconda metà del XVI secolo fu autore di
un saggio₁₀. Filtrò i suggerimenti più radicali e probabilmente
motivati più dalla paura che da convinzione scientifica ed elaborò norme che
ancora ora sono fondamentali. Per esempio l’isolamento delle persone infette.
Proprio al termine del IV capitolo del trattato, ad esempio, viene imposto
l’uso del lazzaretto. Le persone infette debbono essere isolate in luoghi
lontani dal centro cittadino e sorvegliato da guardie che impediscano il
contatto con altre persone. Il lazzaretto era un luogo già conosciuto nel
passato, ma all’epoca piuttosto che essere utilizzato per isolare persone
infette, veniva utilizzato come strumento di prevenzione lasciando in
quarantena forestieri che giungevano sul territorio dopo lunghi viaggi in
sperduti luoghi. Uno dei primi luoghi adibiti alla prevenzione delle malattie
venne istituito già nel 1423 su indicazioni di Bernardino da Siena al Senato
della Repubblica di Venezia. Era chiamato anticamente Nazarethum
(Successivamente chiamata Lazzareto Vecchio). Si trattava dell’isola Santa
Maria di Nazareth dove venivano tenuti in quarantena i marinai e le navi
provenienti dalle tante terre possedute dai Veneziani prima di poter sbarcare
nella Serenissima e dove però l’ospedale collocato (Il termine deriva da
rifugio per gli stranieri, solo successivamente venne utilizzato come luogo di
cura) concedeva vitto e riposo a coloro che si fermavano. Ma il Lazzareto,
ipotizzato da Fiochetto era invece luogo imposto con la forza atto ad isolare
gli ammalati e per molti di questi diventava l’anticamera di una fossa comune
vista la mancanza di cure ₁₁. La lontananza dal centro cittadino di
questi luoghi avrebbe permesso di evitare la promiscuità. Ci sono rimaste
ancora alcune indicazioni storiche di dove furono collocati i lazzaretti (Ve ne
furono sicuramente diversi collocati intorno alla città stessa). Alcune
indicazioni geografiche sono cadute nell’oblio e quindi non si è in grado oggi di
poter individuare i luoghi (per esempio una zona di campagna chiamata “cabane”,
ora dimenticata da qualsiasi mappa storica) in altre, invece, l’individuazione
è stata possibile in quanto se ne è mantenuta viva la memoria per fatti
successi nello stesso luogo. Spesso fatti che non hanno nulla a che fare con
l’argomento trattato. Come, per esempio, un luogo chiamato “Levaldocho”. Si
tratta di un luogo conosciuto ormai in tutto il mondo cristiano con il nome di “Valdocco”,
dove nei successivi secoli è nata la chiesa salesiana creata da uno dei tanti
santi sociali torinesi (San Giovanni Bosco). Un luogo che oggi è inserito nel
centro cittadino, ma che all’epoca non era neppure considerata ancora
periferia. Questo è un periodo nel quale ancora non sono state elaborate
moderne teorie sociali. Quindi le scelte dell’epoca risentono anche di un certo
classismo. Oltre a proporre che questi lazzaretti fossero divisi in modo da
evitare che insieme a persone oneste potessero essere reclusi delinquenti
infetti (Lazzareto speciale), ne vennero istituiti altri che differenziavano le
classi sociali. Lazzaretti per infetti poveri, lazzaretti per sospetti infetti
poveri, lazzaretti per infetti comodi (intendendo per comodi persone
appartenenti a ceti sociali più abbienti), lazzaretti per sospetti infetti
comodi. Per i primi era la città a provvedere le spese per il mantenimento del
vitto e delle guardie a difesa del luogo, mentre per i secondi le spese erano
coperte dal patrimonio personale delle persone li ricoverate. Tutto sommato una
scelta di equità sociale, che non era comune all’epoca in quanto un decreto
speciale dell’Imperatore Carlo V aveva precedentemente stabilito che le spese
della peste dovevano essere totalmente a carico del fisco.
Venne
poi imposto dal protomedico alla città; “Si faccia elezione di medici e
chirurgici di dottrina e pratica, animosi, sani, pazienti, pronti al travaglio,
di buona coscienza e finalmente timorati di Dio, a quali si dia anco casa
separata, e vesta o degno mantello che li faccia conosciuti dal popolo, e che
vadano con guardia sia nella città che fuori nei lazzaretti e in campagna”.
Altra
imposizione proposta dal protomedico alla autorità cittadina fu quella che,
individuata una casa ove insiste il contagio, si procedesse alla soppressione
di tutti gli animali (cani, gatti, galline, colombi) e si procedesse alla
preparazione di veleno (arsenico) per i topi. Che tutti i sindaci dei luoghi
fossero obbligati a dar subito informazione anche dell’eventuale sospetto
contagio in modo da isolare immediatamente le persone sospette dopo visita di
un medico inviato immediatamente dalle autorità e scortato da guardie. Nelle
prescrizioni, non si taceva neppure per la cura delle anime. Tanto è vero che
nel settimo paragrafo del IV capitolo si dava indicazione anche di come
procedere per l’amministrazione dei sacramenti; “Si procurino aver sacerdoti
intelligenti ed esemplari per la cura delle anime, a quali sia data casa
separata per loro e per loro chierici, a quali tutti faccia ad ognuno una sopravveste
di terlizzo, o tela incerata lisciata, che portino andando fuor di casa per
l’amministrazione de sacramenti. E per il Santissimo Sacramento dell’Altare,
gli si faccia una bossoletta posta in una borsa di raso di damasco, pendente da
un cordone di seta posto al collo… e avanti esso vada il chierico con un
lanternino acceso, i quali accompagnati da guardie, ma senz’altro seguito o
accompagnamento”.
Ma
il protomedico non si limitò solo ad ordinare comportamenti sulle persone,
tratto infatti anche norme di sanità pubblica. Un particolare capitolo verrà
indicato per la prevenzione della peste. Al fine di tagliare tutte le
possibilità di diffondersi; “Le bocche dei sepolcri siano otturate
diligentemente e le fessure vengano trattate con ceneraccio e fango” (Un
primo abbozzo di regolamento di polizia cimiteriale, anche se di cimiteri non
se ne parla in quanto sarà una scelta che verrà adottata solo secoli dopo con
l’avvento del potere napoleonico).
E
ancora per quanto riguarda la scienza veterinaria; “Che animali morti
vengano sepolti (Una bella sfida in un mondo dove la fame era all’ordine
del giorno delle classi popolari) e che questi vengano coperti con fango.” Naturalmente
venne toccata dalle indicazioni anche la scienza farmacologica, anche se pure
in questo caso non vi erano provate certezze sul risultato curativo; “Le
infrascritte pillole sono molto laudate a preservarsi dalla pesta, le quali
sono fatte di due parti di aloe, una di perfetta mirra e una di zafferano e per
chi ha il fegato caldo una di sandalo”.
Ora,
a leggere queste cose ai giorni nostri, ci fa capire come nel mondo moderno
sono stati fatti passi giganteschi dell’’umanità verso una vita sanitaria
migliore. Ciò è costato fatica e milioni di vittime. Ed è ancora più deludente
pensare a quanti ancora oggi sottovalutano i presidi sanitari che sono stati
scoperti e che hanno permesso e permettono di salvare così tante vite umane.
Ciò è ulteriormente drammatico se si pensa che con la globalizzazione anche le
malattie hanno una diffusione molto più rapida di ciò che poteva succedere nel
1600.
₁
Benedetto Trompeo “Notizie storiche intorno al Conte Gian Francesco Fiochetto”
– Tipografia Nazionale di Bottero Luigi – Torino, 1867.
₂
Giovanni Voersio, Giornale o diario del contagio in Piemonte negli anni
1630-1631 e del Congresso generale per la pace d’Europa allora tenuto a
Cherasco.
₃
Yersinia pestis, cocco-bacillo Gram-negativo responsabile di altre grandi
epidemie accertate quali quella dell’epoca di Giustiniano del VI secolo, la
peste nera d’Europa che falcidiò il continente dal 1347 al 1353 uccidendo un
terzo della popolazione, la grande peste di Londra, la peste del XIX secolo in
Cina.
₄ “… dapprima il cielo oppresse la terra di densa caligine ed empì le nubi di torbidi calori, poi caldi austri spirarono esalazioni mortifere. Laghi e fonti furono infettate…”
₅
“Modo di conoscere et distinguere gli influssi pestilenziali. Et difendere da
quelli con buoni ordini politici. Le persone, città e luoghi; con la scelta di
alcuni rimedij approuatissimi, facili e di poco costo, tanto presersuatiui
quanto curatiui”. – Raccolti in beneficio de popoli da Agostino Bucci – 1585
₆
Historia della peste ed febbri pestilenziali – Giovan Pietro Trevi - 1629
₇
“Trattato della peste o sia contagio di Torino dell’anno 1630” di Gianfrancesco
Fiochetto Primo medico del Serenissimo Duca di Savoia, Principe di Piemonte, In
Torino, appresso Gio Guglielmo Tisma, 1631.
₈
Confessione di metodo di cura in un processo di stregoneria celebrato nel XVII
secolo nel biellese: “Si piglia l’olio di salvia e poi si recitano sopra
queste parole segnandole con la mano: In nome Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Si reiterano tre volte, e poi si aggiunge che quest’olio ritorni in
santità, come fecero verso di noi le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. E
poi si unge la parte offesa et le ferite, et unta che è la piaga la si lega con
una pezza di camisa portata da un maschio e non da una donna, e si lega la
pezza intraverso così al contrario in forma di croce”.
₉
Capitolo IV “Trattato della peste o sia contagio di Torino dell’anno 1630” di
Gianfrancesco Fiochetto Primo medico del Serenissimo Duca di Savoia, Principe
di Piemonte, In Torino, appresso Gio Guglielmo Tisma, 1631. Con titolo “Istruzione
e modo con il quale si deve procedere nel governo della città e luoghi in tempo
di sospetto del mal pestifero contagioso o già scoperto”
₁₀
“Informazione del pestifero et contagioso morbo il quale affligge et have
afflitto questa città di Palermo” (1576)
₁₁
Si stima che l’epidemia di peste che colpì l’Italia nelle zone del settentrione
tra il 1629 ed il 1633, provocò il decesso di 1.100.000 persone su un totale di
circa 4.000.000.
RICCARDINO MASSA
Riccardino Massa (1956) è nato nel “Canavese” (Piemonte centrale). Dal 1986 al 2020 ha svolto la professione di Direttore di scena al Teatro Regio di Torino. Ha ripreso la regia di Roberto Andò de Il flauto magico di Mozart nei Teatri lirici di Cagliari, Palermo e Siviglia, nonché la regia di Lorenzo Mariani de Un Ballo in Maschera di Verdi e quella di Jean Luis Grinda della Tosca di Puccini, entrambi al teatro Bunka Kaikan di Ueno in Giappone. Ha poi realizzato la messa in scena de L’Orfeo per il festival Casella e recentemente la ripresa della regia di Gregoretti del Don Pasquale di Donizetti al Regio di Torino.

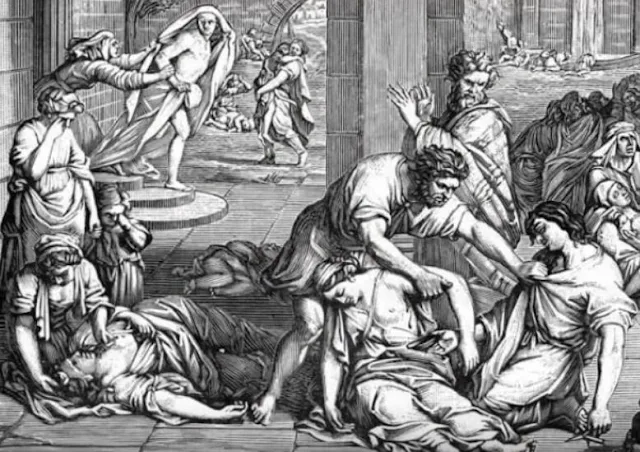

Grazie mille per quanto postato certe cose non si conoscono e non vengono promulgate...ma sono importanti Grazie ancora...ciao...
RispondiEliminaInfiniti complimenti per la tua competenza e la tua abnegazione nella ricerca di questi fatti.
RispondiEliminaAldo DOVO
Ho trovato l'articolo interessante perché ho avuto Modo di scoprire luoghi e storie di una Torino che non smette mai di stupire. Gastaldi.
RispondiEliminaGrazie Riki a parte il saputo sulla peste a Torino ci dai molto in più x capire ed esplorare i tempi storici ed i cambiamenti sanitari e di studio.. Di certo un acconto in più del sapere comune, ancora grazie e continuità.. Walter
RispondiElimina